Attrice, autrice e cantante siciliana, di Avola, classe 1990, Rosy Shoshanna Bonfiglio tiene anche seminari e workshop di formazione per professionisti e aspiranti attori, oltre a curare progetti laboratoriali in cui coniuga l’esperienza del teatro con le tecniche di comunicazione e Coaching.

Rosy Shoshanna Bonfiglio, ti sei formata all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico di Roma, studiando recitazione con grandissimi Maestri. Dopo il diploma ti specializzi con Luca Ronconi e inizi a lavorare con Gabriele Lavia. Qual è l’insegnamento più grande che ti hanno dato?
Per Gabriele partirei da due frasi che ci ripeteva in continuazione: “come nella vita” e “recitare è impossibile”. La prima puntava a farci trovare la naturalezza espressiva, delle battute così come del corpo e della gestualità, che andasse effettivamente a riprodurre modi di parlare, di muoversi, di camminare, propri della vita vera. Quella naturalezza in lui la vedevi chiaramente, è un attore formidabile. Eppure quando sei su un palco, agli inizi soprattutto, sei istintivamente portato a bloccare delle funzioni delle quali normalmente non ti preoccupi nemmeno: sembra difficile persino camminare! Questa naturalezza conviveva certo con una grammatica maniacale: ogni passo, ogni gesto, ogni mignolo che si muovesse sul palco era figlio di una precisione formale impressionante. È stato un maestro di recitazione e di regia per me preziosissimo, fondamentale, gli ho rubato molto. E poi la seconda frase: una sua costante considerazione che metteva in luce quel conflitto continuo che un attore – anche e soprattutto un gigante come lui – vive nel pirandelliano gioco delle parti che tra la vita e il palco sembra una vertigine. C’è in lui una leggerezza, un’enorme simpatia anche, che convivono con una profondità di cui ho avuto la fortuna di ereditare molto. Ricordo le lunghe giornate di prove di ogni spettacolo fatto insieme, da “I giorni del buio” a Ibsen ai “Sei personaggi in cerca d’autore” di Pirandello: un ininterrotto avanti e indietro dal palco al tavolo di regia, era capace di salire e scendere da quelle scalette non so quante volte, senza mangiare nulla tutto il giorno. Concentrato, dedito, attento, maniacale, infaticabile direi. Mi ha trasferito anche il senso di un equilibrio che definirei “musicale” dello spettacolo. La sua è decisamente una direzione orchestrale, in cui il corpo, lo spazio e la parola definiscono una partitura costruita con impeccabile precisione. Questo mi ha sempre affascinato. È un’attitudine che ho mutuato e che mi accompagna sempre nel modo di costruire i miei lavori. La mia successiva passione per la regia ha probabilmente iniziato a sbocciare proprio in quei primi anni accanto a lui, per quanto non me ne accorgessi. E poi condividiamo le radici siciliane, e questo credo sia stato un punto di contatto tra noi sempre molto profondo, come un reciproco riconoscimento in un certo sentire. Gli voglio un gran bene. Luca Ronconi mi ha invece fatto dono della visione, del lampo di un’intuizione che credo di aver colto senza troppo elaborarla: si è come piantata immediatamente dentro la mia coscienza di interprete, sin dal primo giorno di lavoro insieme in quella indimenticabile bolla di Santa Cristina, in Umbria, consegnandomi una chiave pure fondamentale per tutto ciò che è venuto dopo. Chiave per aprire la porta di ogni testo direi. Chiave per trovare la mia piena libertà: ciò che mi si è chiarito in quel periodo con lui è stato come entrare nelle parole e surfarci dentro. Quando si parla di attori “che cantano in ronconiano” penso che la sua formidabile intuizione sia stata spesso fraintesa e non compresa: personalmente ne ho ereditato un preziosissimo tesoro. E poi non dimenticherò mai quella frase, durante una mattinata di lavoro sulle fiabe di Andersen, sempre in Umbria: “Ci sono attori che dal palco ti dicono ‘Io, io, io!’. Cercate di diventare attori che tendendo il braccio dicono allo spettatore “Vieni con me!”.
Oltre alle tue esperienze come interprete, hai anche ricoperto il ruolo di aiuto regia in Divina Commedia Opera Musical, per la regia di Andrea Ortis e le musiche di M. Frisina. Come hai vissuto il passaggio dal palco al lavoro dietro le quinte?
Dico spesso che alcune sensazioni interne, alcuni guizzi della coscienza, mi hanno preceduta nella mia vita anticipando qualcosa che avrei capito meglio più tardi. Quando ho realizzato il primo lavoro come autrice, CAPINERA, mi era stato evidente un interesse fortissimo, una naturale inclinazione, per la costruzione registica di un testo, per quanto in quel caso fossi comunque anche l’interprete dello spettacolo. Dopo il primo anno nel cast di Divina Commedia, come interprete nei panni di Francesca da Rimini e Matelda, in cui mi alternavo con la bravissima Manuela Zanier, storica interprete anche delle precedenti edizioni del musical, Andrea mi propose un passaggio al suo fianco, come aiuto regista. Aveva colto già nell’anno precedente una mia passione per la direzione e la scrittura e la nostra intesa artistica aveva messo capo nei mesi successivi alla realizzazione di una lettura scenica, scritta a quattro mani, sul carteggio amoroso tra Sibilla Aleramo e Dino Campana. La proposta fu quindi quella di affiancare la regia nel restyling dell’intero spettacolo, dalla revisione del libretto a tutte le fasi del processo creativo di ogni reparto. Ricordo che all’epoca questa opportunità mi mandò parecchio in crisi. Qualcosa dentro di me aveva paura di staccarsi dal ruolo di interprete, per quanto riconoscessi nell’intuizione di Andrea una grandissima evidenza, oltre che la preziosa possibilità di imparare molto in quel nuovo ruolo accanto a lui e all’interno di una macchina così grande. Così è stato. L’esperienza è stata molto dura e impegnativa: il lavoro di coordinamento di tutte le funzioni creative e tecniche, oltre a quello più strettamente artistico, richiedeva ritmi massacranti e quando affianchi un regista è importante saper mediare da una parte e interpretare dall’altra, per supportare la sua idea, la sua visione e al contempo “sfidarla” se occorre. Mi è stato molto utile per temprarmi e anche per capire meglio che quella passione per la direzione fosse decisamente qualcosa di più. Per il resto, trovavo estremamente gratificante contribuire alla costruzione dello spettacolo: non ho mai sofferto lo stare lontana dalle luci della ribalta e anzi devo dire che ricordo di aver amato particolarmente quella postazione al tavolo di regia sia durante l’allestimento sia durante le repliche. Mi piaceva vedere le cose pian piano materializzarsi davanti, dopo averle immaginate.
Nel 2016 arriva il tuo debutto sul grande schermo e subito ti aggiudichi un premio come miglior attrice protagonista nell’ambito dell’Eurasia International Film Festival di Mosca con il cortometraggio Amore Panico del regista siciliano Cristian Patanè. Come hai vissuto l’esperienza del set? E come la definiresti rispetto a quella del palco?
Il set di AMORE PANICO in particolar modo fu parecchio sfidante e direi anche faticoso, sia emotivamente sia psicologicamente sia fisicamente. Per una serie di fattori fummo costretti a posticipare le riprese al mese di novembre inoltrato, in una location poco favorevole in inverno. I laghetti di Cavagrande sono selvaggi e affascinanti, ma anche gelidi! L’acqua ha una temperatura estremamente bassa anche in estate e il film prevedeva scene complesse, dal bagno nel lago dei due protagonisti alla fuga angosciante del personaggio che interpretavo, Valentina, in mezzo al bosco, di notte, e così via. È stato certamente molto avvincente, adrenalinico e per certi versi un po’ magico, immerso in un’atmosfera sospesa che ha reso il ritorno alla normalità dopo il set affatto semplice. Certi luoghi naturali hanno in sé questa densità, puoi percepirla chiaramente appena ci metti piede. Cavagrande è di certo uno di questi. Il corto raccontava un incontro d’amore e di morte in un posto evocativo e fervido di significati simbolici in cui, a dispetto della finzione cinematografica, era impossibile rimanere immuni a una certa impressione. Lo dico letteralmente, perché lo spazio e il tempo di quella settimana, oltre che la storia che raccontavamo, si erano fisicamente e interiormente impressi nella mia persona, mi sentivo lontana e altra da come fossi partita. Naturalmente ogni set è una storia a sé, ci sono livelli diversi di coinvolgimento e anche di agio direi, proprio in virtù di tutti i fattori che compongono l’esperienza. Su un piano più generale direi che il mio rapporto con la macchina da presa si sia molto modificato in questi anni. Probabilmente acquisire maggiore sicurezza in me stessa mi rende oggi più libera e disinvolta anche davanti all’obiettivo: non a caso mi sono sempre più appassionata anche al linguaggio video, con cui sto molto lavorando ultimamente. Di certo la dimensione fisica, chimica, dell’incontro con gli spettatori, l’energia che si sprigiona quando quel miracolo insondabile del teatro si verifica, è ineguagliabile, e rimane in assoluto più vicina al mio sentire e alla mia natura. E poi da qualche tempo devo ammettere che il lavoro costante con le immagini, con il montaggio e la regia video, mi sta solleticando un desiderio di esplorare ulteriormente quella dimensione espressiva. Chissà, magari dopo l’esperienza “dietro le quinte” potrà esserci in futuro un set “dietro la macchina da presa”!
La scrittura incrocia il teatro e la musica, ma trova anche una sua via indipendente con la pubblicazione del tuo primo libro: una raccolta di poesie dal titolo Nei giardini dell’Erebo, pubblicata durante il lockdown in self-publishing. Perché questo titolo, perché in self pubblishing e perché farlo uscire proprio nel periodo di quarantena?
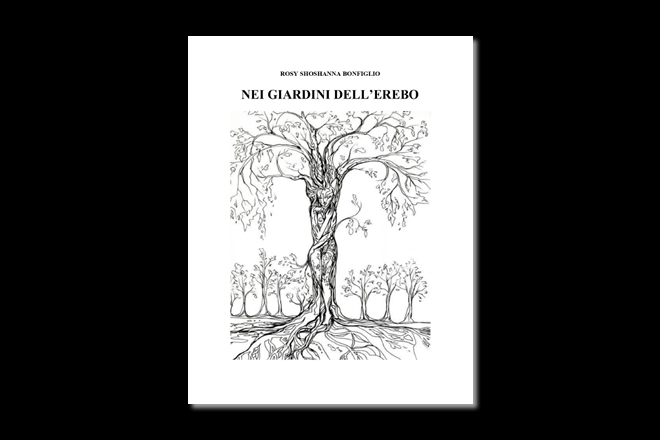
La quarantena è stata un’esperienza molto particolare: ha innescato un dialogo tra me e la vita che ha messo capo a dubbi, conferme, smentite, paure, slanci, prese di coscienza e di posizione, messe a fuoco. Di certo qualcosa in me è rimasto profondamente colpito dal fenomeno “evento inaspettato che cambia tutto e per tutti”. Ho incontrato spesso la dimensione più imprevedibile della vita in molti momenti del mio percorso, legata sempre a situazioni più strettamente private, personali, che quindi non avessero una portata così ampia, globale, come quella che abbiamo vissuto in questi mesi. Il libro era il mio cofanetto di fioritura da regalare al mondo: è così che lo sentivo e che lo sento. L’Erebo è per il mondo classico l’oscura profondità della terra, mentre il Giardino rappresenta in qualche modo l’espressione più vitale, fiorita della natura, e al contempo sacra, carica di significati simbolici. C’è una luce, una pienezza che colma e completa l’attraversamento di quel territorio sotterraneo. Le poesie del libro percorrono infatti questa stratificazione, con un’impennata importante verso la fine, che culmina in un componimento dal sapore esplicitamente spirituale. Trascorsa la prima settimana di quarantena, da sola in casa, a Milano, ero in preda a un’angoscia per il mondo che non avevo mai sentito prima così forte: vedevo nel fenomeno in corso dei richiami enormemente più ampi alla nostra responsabilità come esseri umani, percepivo i messaggi di una natura, di una vita, che non accetta più lo spreco della sua bellezza. Quando allo scattare della seconda settimana qualcosa in me ha fatto click, ho capito che il libro avrebbe rappresentato una missione nuova per me, un atto di amore con cui innescare un processo di collettiva fioritura. Mi sono allontanata dai social per parecchie settimane, dedicandomi un silenzio totale. Riflettevo su come l’Arte dovesse reagire all’emergenza e su cosa un artista fosse chiamato a cogliere. Mi sono risposta che volessi rispondere semplicemente all’amore che – più forte che mai – in me sbocciava per la vita e per tutti noi, e quindi al posto di scrivere un sms a ogni abitante della terra (cosa abbastanza difficile da realizzare!) per esortarlo e fare tesoro del tempo, il libro mi è parso l’oggetto migliore per mettere in circolo questo messaggio. È il mio personale dono del viaggio che mi ha guarita, con la speranza che parli agli altri e che ognuno possa trovarci dentro qualcosa di utile per il proprio giardino interiore. Quando tutto questo mi si è improvvisamente chiarito, non ho avuto esitazioni e ho deciso di pubblicare la raccolta immediatamente. Ecco perché il self-publishing: non c’era tempo da perdere e bisognava che quel dono venisse prima possibile consegnato. Era quello il suo momento giusto, e io ho dovuto solo assecondarlo.
Hai dichiarato: «Non sento le mie attività come separate, che si tratti di musica, recitazione, scrittura, persino il coaching! Per me c’è una perfetta coincidenza…». Cosa volevi dire?
Ad oggi mi è abbastanza chiaro cosa a me interessi fare, e cioè occuparmi delle persone, della loro crescita interiore, spirituale, emotiva, della loro fioritura. Questo passa per l’incontro, inteso come scambio, confronto e supporto, nel caso del Coaching, come segno, rappresentazione, composizione (visiva, letteraria, sonora che sia) nel caso dell’Arte. Mi interessa facilitare negli altri la fioritura di cui parlavo prima. Questa ha a che fare innanzitutto con la capacità di ognuno di contattare tutte le dimensioni di cui è composto: quella intellettuale, quella fisica e quella spirituale. Successivamente si tratta di metterle in contatto, le une con le altre, e di allinearle. Questo passaggio di riconoscimento e sintesi è fondamentale e propedeutico a qualsiasi sviluppo. Credo che una delle trappole più frequenti del nostro tempo sia il fatto di essere frammentati, parziali nella nostra consapevolezza ed espressione di noi.
Ciò di cui mi occupo è facilitare quel riconoscimento, attraverso esperienze e strumenti differenti, il dialogo e l’arte. Mi risulta molto chiaro quindi cosa io faccia, un po’ meno a volte come si chiami!
Abbiamo tanto bisogno di dare dei nomi alle cose e io personalmente preferisco i verbi! Quando devo elencare i miei profili professionali mi sento sempre un po’ a disagio: attrice, cantante, autrice, coach, e ancora “acting coach” e poi “business coach”, che pure sono due cose ben diverse… mi sembra una successione di parole dispersiva, per quanto inevitabile nella nostra società. Io mi sento perfettamente agganciata alla mia motivazione esistenziale sia che mi trovi su di un palco sia che faccia una sessione a un cliente. Mi sento attiva nel favorire nell’altro un’esperienza di crescita umana – a livelli diversi naturalmente in base ai differenti contesti – e aggiungerei di incontro, attraverso di me, con se stessi.
Quali sono, infine, i progetti in cantiere?
Il libro è diventato il motore propulsore di un movimento più ampio e in continua espansione.
Prima parlavo di tre dimensioni che insieme restituiscono unità a ogni essere umano: quella intellettuale, quella spirituale e quella fisica. Penso che l’arte sia in assoluto il più grande mezzo di unificazione di queste tre dimensioni: per questo mi sta a cuore diffonderla anche da un punto di vista più concettuale e filosofico, quindi educativo, oltre che attraverso la fruizione che gli altri possano farne in quanto lettori, spettatori, ascoltatori, etc. Oltre alla diffusione cartacea e audio-visiva delle poesie (con il progetto delle Poesie Sonore, disponibili sul mio canale Youtube), il libro sta assumendo una nuova forma, attraverso la collaborazione con altri artisti, di cui prestissimo svelerò i dettagli sui miei canali.
Al contempo sto ultimando il mio primo romanzo, a cui lavoro da qualche anno, e scrivendo una seconda raccolta, iniziata all’inizio del 2020.
 La Gazzetta dello Spettacolo Il Quotidiano di Notizie sullo ShowBiz
La Gazzetta dello Spettacolo Il Quotidiano di Notizie sullo ShowBiz






