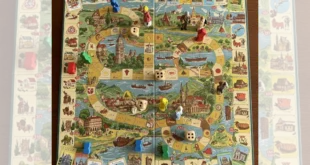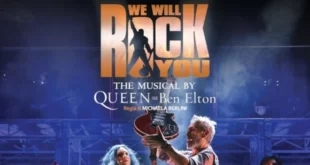La grande corsa, di Selena Cravotto
Selena Cravotto si è affacciata sul panorama editoriale con il romanzo La grande corsa, pubblicato con la casa editrice Affiori.
A essere narrata raccontata da Selena Cravotto per “La grande corsa” è una storia che parte da Torino e arriva fino al Monte Bianco, attraversando la Francia. È una riflessione sull’ambizione e sui sogni attraverso gli occhi di Sveva, una giovane donna che un tempo odiava correre, e su ciò che la separa dal compiere un’impresa quasi impossibile: partecipare all’iconica gara Mont Blanc Sky Run. Centocinquanta chilometri e ottomila metri di dislivello, tutto a piedi, senza mai fermarsi, nemmeno di notte.
Nel mezzo si svolge la sua trasformazione fisica, mentale e personale, un percorso che si sviluppa chilometro dopo chilometro, come in un mémoire. Ma questo viaggio non è solo una sfida sportiva. È anche l’inaspettata ricostruzione del rapporto con il padre, che forse, senza rendersene conto, la stava allenando per sfidare il suo stesso divieto di partecipare a una gara tanto estrema.
Quando un grave incidente mette in discussione il senso dell’intera impresa, Sveva dovrà confrontarsi con le sue motivazioni più profonde.
Selena Cravotto, benvenuta su La Gazzetta dello Spettacolo. La grande corsa è il tuo romanzo d’esordio. Quando hai capito che questa storia andava raccontata in un libro e non, ad esempio, in un blog o in un saggio?
Avevo in mente questa storia da diversi anni. Io stessa corro da molto tempo e c’era una domanda che mi veniva posta spesso: perché lo fai? Sentivo che in quella risposta era racchiuso l’insieme così straordinario di sensazioni fisiche ed emotive che nonostante la fatica rendono l’esperienza della corsa qualcosa di così umano e trasformativo. Avevo un blog, eppure gli mancava qualcosa. C’erano l’allenamento, le gare, le sensazioni. Episodi a sé stanti. Serviva spazio per raccontare come questi si intrecciano e influenzano le persone anche al di fuori. Spazio per la vita che accade tra un allenamento e l’altro. Così ho sviluppato l’idea di un romanzo dove i livelli narrativi, vita e corsa, si intrecciano costantemente. Gli allenamenti entrano nella vita di Sveva e cambiano lei, il suo corpo, le relazioni. Ma anche la vita, il mondo reale con le proprie regole, entra in quello idealmente protetto della corsa, mettendone in discussione l’intoccabilità e anche le motivazioni più profonde di Sveva.
La narrazione ha uno stile vicino al mémoire. Da cosa è arrivata l’ispirazione che ti ha condotto a questa scelta narrativa?
Da queste premesse, la scelta della forma del memoire è avvenuta in modo naturale, quasi suggerita dalla struttura del testo stesso. La storia procede veloce, come in una sequenza di fotografie e ricordi che compongono un’immagine più ampia con una struttura ben delineata.
La corsa è il trait d’union tra te e Sveva?
Sveva odiava correre e il modo singolare in cui inizia si ispira a un episodio autobiografico. Si trova con il padre e la sorella Asia sul Montebianco e vede qualcosa che cambia per sempre il suo modo di pensare alla fatica. Una specie di epifania. È esattamente così che ho iniziato a correre, più di 15 anni fa. Ma i punti in comune con Sveva sono tanti, a partire dalla figura del padre. Al mio, mi sono ispirata per costruire il personaggio di Vittorio. Mentre lo scrivevo e lo rileggevo più volte però, questo romanzo ha iniziato a diventare sempre più autonomo, trovavo elementi che andavano oltre la mia esperienza personale. Mi rendevo conto che tratteggiava archetipi che possono risuonare con l’esperienza di qualcun altro. Qualcuno potrebbe riconoscerci un proprio mentore, un divieto che ha innescato una necessità di riscatto, una perdita, una rinascita. Chi lo ha letto, me ne ha restituito interpretazioni nuove e questo mi fa capire che questa storia è andata oltre la mia.
Nel romanzo, il rapporto padre-figlia gioca un ruolo centrale. Perché trattare questa tematica?
Il padre ha un ruolo centrale. È sia ostacolo che mentore, avversario e compagno di squadra. Il rapporto tra Sveva e il padre evolve pagina dopo pagina. Mentre scrivevo, frequentavo la Scuola Holden e lavoravo alla prima stesura del romanzo. Il docente mi ha chiesto perché proprio Sveva e non un altro personaggio intraprende questa impresa eccezionale. L’intera vicenda tende verso l’obbiettivo di correre una gara straordinaria, sul Montebianco, lunga 150 chilometri. Ma come ha suggerito poi l’autore Alessio Romano, che ha presentato con me il romanzo al Circolo dei lettori di Torino, è la figura stessa del padre a essere una “montagna”. Per l’unicità del proprio personaggio, la postura, la sfida e l’ispirazione che costituisce. Nel lungo percorso che separa Sveva da questa impresa, lei e il padre Vittorio a tratti si allontanano e si riavvicinano, accomunati non solo più dall’essere un padre e una figlia, ma ora entrambi runner. Una condizione che offre a un rapporto di genitore-figlio un’arena nuova e comune di confronto, seppure ignorando le vere reciproche motivazioni. Attraverso un cambio di punto di vista che avviene nella seconda parte, il romanzo esplora come l’idea che si ha dell’altro possa rivelarsi lontana da ciò che egli sta realmente vivendo.
Resistenza, tenacia, rigore e disciplina, ma anche ambizioni, ostacoli da superare, sogni. La crescita personale, per avvenire, deve contenere un po’ di tutti questi elementi?
Un tempo avrei detto di sì, ma oggi aggiungo un elemento che ritengo fondamentale e che ho compreso nel tempo. Il rispetto per se stessi. Non c’è sfida che si possa intraprendere se non ci siamo noi. Senza preservare la propria salute fisica e mentale. Questo vuol dire che, alla disciplina e alla costanza, va affiancato l’ascolto. Credo che ci sia una voce potente dentro di noi che sa ciò che vogliamo davvero. È fondamentale avere un sogno e a volte raggiungerlo prende molto tempo. Per questo, se in qualsiasi momento del viaggio ci si accorge di non stare più bene nel fare i gesti quotidiani necessari a raggiungerlo, è importante domandarsi se è ancora ciò che desideriamo davvero.
In chiusura, quale messaggio vorresti che arrivasse a chi ti legge?
Vorrei confutare l’idea che la corsa sia uno sport solitario. Seppur individuale, l’intensità di questa esperienza diventa una condizione comune. Dopo lunghi tratti di strada, ci si accorge che gli avversari sono compagni, testimoni della stessa fatica, speranza e umanità. Lo chiamo paradosso della solitudine. Proprio in quel vissuto ci si riconosce, si condivide qualcosa di profondo. Oltre a questo vorrei diffondere l’idea che in noi c’è più forza di quanto a volte pensiamo. Si tende a credere che chi fa sport abbia sempre voglia di allenarsi e abbia una forza di volontà particolare. Ma probabilmente ha “solo” instaurato una routine virtuosa. Anche se quella mattina presto, al buio e col freddo, non ha voglia di alzarsi e andare a correre, lo farà perché è una sua abitudine, che dopo restituirà un rinforzo positivo di benessere e soddisfazione. Ciò che ci separa da questa routine sono le aspettative, troppo rigide e irrealistiche. Prima o dopo ci sarà un imprevisto, proprio quando la motivazione non è più al massimo, e si abbandona la routine. Anziché riprenderla alla prima occasione, compare l’idea di aver danneggiato tutto. Un modo per spezzare questo bisogno di perfezionismo può essere quello di avere aspettative più realistiche, a prova di imprevisto. Anziché correre tutti i giorni, correre almeno una volta a settimana. Qualsiasi sia l’obiettivo, lo sentiremo avvicinarsi anziché sfuggire.
 La Gazzetta dello Spettacolo Il quotidiano dello ShowBiz
La Gazzetta dello Spettacolo Il quotidiano dello ShowBiz